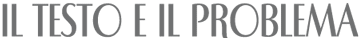Issuu
|
|
IL TESTO E IL PROBLEMA
La Divina Commedia
|
|
|
UNITÀ C
La letteratura religiosa
|
UNITÀ E
Il Dolce Stil Novo
|
UNITÀ F
La poesia comico-realistica
|

ANTONINO SCIOTTO
Ideologie e metodi storici

|

Queste parole sono state pronunciate da Piero Calamandrei in un discorso del 1950. Le riproponiamo a insegnanti e studenti per la loro impressionante attualità.
Facciamo l'ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza. Non vuol fare la marcia su Roma e trasformare l'aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura.
Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali. C'è una certa resistenza; in quelle scuole c'è sempre, perfino sotto il fascismo c'è stata. Allora, il partito dominante segue un'altra strada (è tutta un'ipotesi teorica, intendiamoci). Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. Le scuole del suo partito, di quel partito.
Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi. Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole, perché in fondo sono migliori si dice di quelle di Stato. E magari si danno dei premi, come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche alle scuole private. A "quelle" scuole private. Gli esami sono più facili, si studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata.
Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare la prevalenza alle sue scuole private. Attenzione, amici, in questo convegno questo è il punto che bisogna discutere. Attenzione, questa è la ricetta. Bisogna tener d'occhio i cuochi di questa bassa cucina. L'operazione si fa in tre modi: ve l'ho già detto: rovinare le scuole di Stato. Lasciare che vadano in malora. Impoverire i loro bilanci. Ignorare i loro bisogni. Attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole private. Non controllarne la serietà. Lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i titoli minimi per insegnare. Lasciare che gli esami siano burlette. Dare alle scuole private denaro pubblico. Questo è il punto. Dare alle scuole private denaro pubblico.
Piero Calamandrei - discorso pronunciato al III Congresso in difesa della Scuola nazionale a Roma l'11 febbraio 1950
|
|
|
|
|
| Dante Alighieri |
| Divina Commedia |
|
Inferno, II, 37-142; Paradiso, XVII, 100-142; Purgatorio, XXIV, 49-63 |
|
|
|
Un poema ispirato da Dio |
|
|
|
|
|
Stampa - Indice biblioteca online
[Inferno, canto II, vv. 37-142]
Dopo lo smarrimento nella selva oscura e l’incontro con Virgilio narrati nel canto I [DIV1a], Dante si è detto pronto a iniziare il viaggio attraverso l’oltretomba. Ma, sul fare della sera, il pellegrino è assalito dai dubbi. Perché un privilegio concesso in passato solo a Enea e a san Paolo dovrebbe ora toccare a lui? Avventurarsi in un viaggio del genere non è forse un’azione temeraria [DIV2a]? Ai dubbi di Dante Virgilio risponde illustrando i motivi che lo hanno indotto a muoversi in suo soccorso. È stata la Madonna a impietosirsi della sua condizione di peccatore ed a chiedere – mediante santa Lucia – l’intervento di Beatrice. Quest’ultima non ha esitato a lasciare il suo seggio celeste per scendere all’Inferno, o più precisamente al Limbo, luogo in cui si trovano i grandi spiriti dell’antichità pagana. In forza dell’aiuto di queste «tre donne benedette» – argomenta ora Virgilio – Dante può intraprendere il suo viaggio senza timore. Indugiare ulteriormente sarebbe anzi segno di «viltà», ossia di una colpevole sottovalutazione delle proprie forze e dell’alto compito che la Provvidenza ha voluto assegnare al poeta. E qual è quei che disvuol ciò che volle
e per novi pensier cangia proposta,
sì che dal cominciar tutto si tolle, 39 tal mi fec’io ’n quella oscura costa,
perché, pensando, consumai la ’mpresa
che fu nel cominciar cotanto tosta1. 42 «S’i’ ho ben la parola tua intesa»,
rispuose del magnanimo quell’ombra,
«l’anima tua è da viltade offesa; 45 la qual molte fiate l’omo ingombra
sì che d’onrata impresa lo rivolve,
come falso veder bestia quand’ombra2. 48 Da questa tema a ciò che tu ti solve,
dirotti perch’io venni e quel ch’io ’ntesi
nel primo punto che di te mi dolve3. 51 Io era tra color che son sospesi,
e donna mi chiamò beata e bella,
tal che di comandare io la richiesi4. 54 Lucevan li occhi suoi più che la stella;
e cominciommi a dir soave e piana,
con angelica voce, in sua favella5: 57 “O anima cortese mantoana,
di cui la fama ancor nel mondo dura,
e durerà quanto ’l mondo lontana, 60 l’amico mio, e non de la ventura,
ne la diserta piaggia è impedito
sì nel cammin, che vòlt’è per paura6; 63 e temo che non sia già sì smarrito,
ch’io mi sia tardi al soccorso levata,
per quel ch’i’ ho di lui nel cielo udito7. 66 Or movi, e con la tua parola ornata
e con ciò ch’ha mestieri al suo campare,
l’aiuta sì ch’i’ ne sia consolata8. 69 I’ son Beatrice che ti faccio andare;
vegno del loco ove tornar disio;
amor mi mosse, che mi fa parlare9. 72 Quando sarò dinanzi al segnor mio,
di te mi loderò sovente a lui”.
Tacette allora, e poi comincia’ io10: 75 “O donna di virtù sola per cui
l’umana spezie eccede ogne contento
di quel ciel c’ha minor li cerchi sui, 78 tanto m’aggrada il tuo comandamento,
che l’ubidir, se già fosse, m’è tardi;
più non t’è uo’ ch’aprirmi il tuo talento11. 81 Ma dimmi la cagion che non ti guardi
de lo scender qua giuso in questo centro
de l’ampio loco ove tornar tu ardi12”. 84 “Da che tu vuo’ saver cotanto a dentro,
dirotti brievemente”, mi rispuose,
“perch’io non temo di venir qua entro13. 87 Temer si dee di sole quelle cose
c’hanno potenza di fare altrui male;
de l’altre no, ché non sono paurose14. 90 I’ son fatta da Dio, sua mercé, tale,
che la vostra miseria non mi tange,
né fiamma d’esto ’ncendio non m’assale15. 93 Donna è gentil nel ciel che si compiange
di questo ’mpedimento ov’io ti mando,
sì che duro giudicio là sù frange16. 96 Questa chiese Lucia in suo dimando
e disse: – Or ha bisogno il tuo fedele
di te, e io a te lo raccomando17 –. 99 Lucia, nimica di ciascun crudele,
si mosse, e venne al loco dov’io era,
che mi sedea con l’antica Rachele18. 102 Disse: – Beatrice, loda di Dio vera,
ché non soccorri quei che t’amò tanto,
ch’uscì per te de la volgare schiera? 105 Non odi tu la pieta del suo pianto,
non vedi tu la morte che ’l combatte
su la fiumana ove ’l mar non ha vanto19? – 108 Al mondo non fur mai persone ratte
a far lor pro o a fuggir lor danno,
com’io, dopo cotai parole fatte, 111 venni qua giù del mio beato scanno,
fidandomi del tuo parlare onesto,
ch’onora te e quei ch’udito l’hanno20”. 114 Poscia che m’ebbe ragionato questo,
li occhi lucenti lagrimando volse,
per che mi fece del venir più presto21. 117 E venni a te così com’ella volse:
d’inanzi a quella fiera ti levai
che del bel monte il corto andar ti tolse22. 120 Dunque che è? perché, perché restai,
perché tanta viltà nel core allette,
perché ardire e franchezza non hai, 123 poscia che tai tre donne benedette
curan di te ne la corte del cielo,
e ’l mio parlar tanto ben ti promette?»23. 126 Quali fioretti dal notturno gelo
chinati e chiusi, poi che ’l sol li ’mbianca,
si drizzan tutti aperti in loro stelo, 129 tal mi fec’io di mia virtude stanca,
e tanto buono ardire al cor mi corse,
ch’i’ cominciai come persona franca24: 132 «Oh pietosa colei che mi soccorse!
e te cortese ch’ubidisti tosto
a le vere parole che ti porse25! 135 Tu m’hai con disiderio il cor disposto
sì al venir con le parole tue,
ch’i’ son tornato nel primo proposto26. 138 Or va, ch’un sol volere è d’ambedue:
tu duca, tu segnore e tu maestro».
Così li dissi; e poi che mosso fue, 141 intrai per lo cammino alto e silvestro27. [Paradiso, canto XVII, vv. 100-142]
Quella che segue è la conclusione del canto XVII, di cui abbiamo riportato la prima parte nel precedente approfondimento [DIV7]. Cacciaguida, rispondendo ai dubbi di Dante circa l’opportunità di scrivere tutto ciò che ha appreso nel corso del suo viaggio, lo invita a non nascondere nulla di quanto gli è stato mostrato. La sua «visione» dovrà essere a tutti «manifesta» perché la verità, anche se può essere sgradita, si impone come un dovere morale. Del resto, non a caso a Dante è stata offerta questa visione, e non a caso il cielo ha voluto che gli fossero mostrati solo personaggi noti: tutto risponde a un disegno provvidenziale, in cui l’opera poetica di Dante dovrà servire a correggere i peccati dell’umanità traviata. Il compito che Cacciaguida impone a Dante è dunque un altro indizio dell’ispirazione divina della sua opera. Poi che, tacendo, si mostrò spedita
l’anima santa di metter la trama
in quella tela ch’io le porsi ordita, 102 io cominciai, come colui che brama,
dubitando, consiglio da persona
che vede e vuol dirittamente e ama28: 105 «Ben veggio, padre mio, sì come sprona
lo tempo verso me, per colpo darmi
tal, ch’è più grave a chi più s’abbandona; 108 per che di provedenza è buon ch’io m’armi,
sì che, se loco m’è tolto più caro,
io non perdessi li altri per miei carmi29. 111 Giù per lo mondo sanza fine amaro,
e per lo monte del cui bel cacume
li occhi de la mia donna mi levaro, 114 e poscia per lo ciel, di lume in lume,
ho io appreso quel che s’io ridico,
a molti fia sapor di forte agrume30; 117 e s’io al vero son timido amico,
temo di perder viver tra coloro
che questo tempo chiameranno antico31». 120 La luce in che rideva il mio tesoro
ch’io trovai lì, si fé prima corusca,
quale a raggio di sole specchio d’oro32; 123 indi rispuose: «Coscienza fusca
o de la propria o de l’altrui vergogna
pur sentirà la tua parola brusca33. 126 Ma nondimen, rimossa ogne menzogna,
tutta tua vision fa manifesta;
e lascia pur grattar dov’è la rogna34. 129 Ché se la voce tua sarà molesta
nel primo gusto, vital nodrimento
lascerà poi, quando sarà digesta35. 132 Questo tuo grido farà come vento,
che le più alte cime più percuote;
e ciò non fa d’onor poco argomento36. 135 Però ti son mostrate in queste rote,
nel monte e ne la valle dolorosa
pur l’anime che son di fama note, 138 che l’animo di quel ch’ode, non posa
né ferma fede per essempro ch’aia
la sua radice incognita e ascosa, 141 né per altro argomento che non paia37». [Purgatorio, canto XXIV, vv. 49-63]
Nel girone dei golosi del Purgatorio, Dante incontra un poeta duecentesco, Bonagiunta Orbicciani da Lucca, esponente della scuola siculo-toscana. Nel colloquio tra i due rimatori, Bonagiunta descrive le caratteristiche della poesia dantesca, in versi destinati a divenire famosi perché in essi si incontra per la prima volta l’espressione «dolce stil novo». Ma il breve brano che riportiamo – come vedremo in sede di approfondimento – è anche suscettibile di un’interpretazione meno immediata. «Ma dì s’i’ veggio qui colui che fore
trasse le nove rime, cominciando
‘Donne ch’avete intelletto d’amore’»38. 51 E io a lui: «I’ mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
ch’e’ ditta dentro vo significando»39. 54 «O frate, issa vegg’io», diss’elli, «il nodo
che ’l Notaro e Guittone e me ritenne
di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo40! 57 Io veggio ben come le vostre penne
di retro al dittator sen vanno strette,
che de le nostre certo non avvenne41; 60 e qual più a gradire oltre si mette,
non vede più da l’uno a l’altro stilo»;
e, quasi contentato, si tacette42. 63

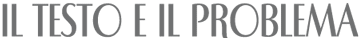
IL TESTO
Una questione (apparentemente) semplice
I brani dell’Inferno e del Paradiso presentati in quest’approfondimento enunciano in maniera assai esplicita la finalità provvidenziale del viaggio di Dante. Tanto nel racconto di Virgilio quanto nelle parole di Cacciaguida, si sottolinea come la visione offerta al pellegrino risponda a un preciso disegno divino. Sembra dunque discenderne l’affermazione di un’investitura soprannaturale, che conferisce alla poesia di Dante i caratteri della profezia.
Dalla Madonna a Virgilio
Tale affermazione è assai trasparente nel II canto dell’Inferno. Dante ha appena protestato la sua inadeguatezza alla missione che gli è stata proposta da Virgilio, dicendosi indegno di compiere un’impresa simile a quella di Enea o a quella di san Paolo [DIV2a]. Per confutare quest’assunto – che il poeta latino attribuisce alla «viltà» di Dante, ossia a una sua colpevole sottovalutazione delle proprie forze e del proprio compito – Virgilio ricorre a un lungo flashback, costruito incastrando un discorso diretto dentro l’altro. Dante poeta, narratore dell’opera, cede la parola – come spesso avviene – al personaggio di Virgilio. E nel racconto di quest’ultimo, dopo un’ampia introduzione (vv. 43-57), sono inserite le parole che in precedenza gli sono state dette da Beatrice (vv. 58-74; vv. 85-114) nonché le risposte e le domande che il poeta latino ha rivolto alla donna (vv. 76-84). Nel discorso di Beatrice sono inoltre inserite le parole di santa Lucia (vv. 103-108) e quelle precedentemente rivolte dalla Madonna alla stessa Lucia (vv. 98-99).
L’episodio ha suscitato, naturalmente, un ampio dibattito critico volto a ricostruirne il senso allegorico. Come è noto, si ritiene che Virgilio rappresenti la ragione e Beatrice la teologia; ma in questo caso l’interpretazione deve necessariamente essere più sottile. Tra le ipotesi più accreditate, c’è quella che vede nelle tre «donne benedette» tre diversi aspetti della Grazia; la Vergine rappresenterebbe la grazia preveniente, che Dio dona all’uomo a prescindere dai suoi meriti (nell’ultimo canto del Paradiso, infatti, Dante dirà che Maria «liberamente al dimandar precorre»; Paradiso, XXXIII, v. 18 [DIV14a]); Lucia sarebbe la Grazia illuminante, che infonde nell’uomo virtù benefiche; e Beatrice la Grazia cooperante, che guida l’uomo a compiere il bene.
Quale che sia l’esatto significato allegorico di queste figure (di cui al lettore, peraltro, rimarrà comunque impressa soprattutto la viva e affettuosa sollecitudine per la sventura del protagonista), è chiaro il senso di questo prologo in cielo: esso vale a conferire al viaggio di Dante un significato universale, garantito dall’intervento celeste, e alle sue parole di poeta un’autorità che non poteva discendere dalle sue limitate forze umane.
Cacciaguida, Beatrice, san Pietro
La conclusione del colloquio con Cacciaguida confermerà la funzione attribuita dalla Provvidenza al viaggio dantesco. Il trisavolo del poeta precisa che tutti gli incontri fino a quel momento capitati a Dante rispondevano a una precisa strategia: quella di farlo parlare con persone note, al fine di attirare l’animo dei lettori e convincerli a prestar fede alle verità contenute nel libro.
Nel testo di Dante quest’intento didascalico è enunciato con uno straordinario calore di poesia. Il brano del XVII del Paradiso tocca a fondo il lettore perché chiama in causa la dimensione etica della letteratura, il suo configurarsi come impegno di verità e la necessità, per ogni uomo degno della propria natura, di combattere per la giustizia e pagare il prezzo della propria battaglia. In questo senso, il canto di Cacciaguida ci parla un linguaggio attuale, e può comunicarci un messaggio di impegno etico anche a prescindere dall’orizzonte di cultura e di pensiero in cui esso è nato.
Rimanendo però nell’ambito del nostro approfondimento – un ambito necessariamente circoscritto – è il caso di ricordare che anche in altri passi del Paradiso si ribadisce il disegno provvidenziale che sta dietro la scrittura della Commedia. Quando Beatrice, in cima alla montagna del Purgatorio, prepara Dante ad assistere alla vicenda allegorica del carro [DIV9b], la donna gli rivolge parole che confermano la funzione profetica del suo viaggio:
Però, in pro del mondo che mal vive,
al carro tieni or li occhi, e quel che vedi,
ritornato di là, fa che tu scrive43.
E sarà addirittura san Pietro, al termine della sua celebre invettiva contro la degenerazione morale della Chiesa, a ricordare a Dante l’obbligo della verità e ad invitarlo a non nascondere nulla di quanto gli è stato rivelato [DIV9a]. IL PROBLEMA
Finzione o realtà?
Ma i passi che abbiamo citato – per quanto esplicita sia la dichiarazione, in essi contenuta, circa le ragioni per cui Dio ha voluto che Dante scrivesse quest’opera – non sciolgono ancora un interrogativo fondamentale. Posto che un’opera di poesia è una finzione – e questo Dante lo sapeva benissimo, tant’è vero che utilizzava con somma maestria la profezia come espediente narrativo [DIV7] – non dovremo considerare finzione anche l’investitura divina di Dante? O ci sono invece ragioni per prendere sul serio queste sue affermazioni sulla propria ispirazione profetica?
Si potrebbe osservare, a sostegno di quest’ultima tesi, che l’ispirazione divina che accomuna poeti e profeti è stata secondo Dante concessa ai grandi poeti precristiani [DIV2a] i quali non avrebbero potuto altrimenti prevedere la nascita di Cristo alcuni decenni prima che essa avvenisse [DIV2b]. Ma l’osservazione, se schiude la giusta prospettiva sull’orizzonte di pensiero in cui va collocata l’opera dantesca (evidenziando quantomeno la possibilità che poesia e profezia siano in esso davvero accomunate), non risponde ancora alla domanda fondamentale: Dante era davvero convinto che la Commedia fosse un poema ispirato da Dio? La questione ha implicazioni di intuibile importanza e si collega tra l’altro strettamente al problema della vera natura dell’allegoria dantesca. Richiamiamo quindi, per provare a rispondere, le considerazioni che abbiamo già svolto trattando tale questione; considerazioni che proveremo a integrare discutendo il brano del Purgatorio inserito nel presente approfondimento.
L’allegoria dei teologi
Come sappiamo, Dante – nell’Epistola a Cangrande [G36] – invita a leggere la sua opera secondo l’allegoria dei teologi, ossia secondo un tipo di interpretazione che ne presuppone la verità letterale. Da questo, come abbiamo detto in altra sede [DIV1c], non deve però dedursi «che Dante abbia creduto davvero di aver fatto il viaggio in oltretomba in corpo ed anima, oppure che abbia voluto far sì che il lettore credesse alla realtà di esso viaggio»1. Nella Commedia infatti è possibile distinguere due momenti: quello “oggettivo” (la rappresentazione dell’oltretomba, dei dannati e dei beati, dei castighi e dei premi, ecc.) e quello “soggettivo” (il viaggio che Dante narra di aver compiuto). Un’attenta interpretazione dell’Epistola a Cangrande ci consente di concludere che la lettura secondo l’allegoria dei teologi – che presuppone la verità del senso letterale – vada applicata solo alla componente oggettiva dell’opera, ossia alla rappresentazione dello «stato delle anime dopo la morte». Insomma, Dante vuole che noi crediamo – in quanto egli stesso ci crede – alla verità letterale di tutto ciò che ci racconta di aver visto. Non vuole invece che crediamo alla lettera all’esperienza d’eccezione del suo viaggio, che va invece considerata un’allegoria poetica, una bella finzione che rappresenta il percorso di conoscenza e purificazione che è possibile e necessario per ogni uomo.
Non è da poco, però, l’affermazione che – analogamente a quanto avviene per i testi sacri – nella Commedia vada considerato vero alla lettera tutto ciò che riguarda l’oggetto dell’apprendimento di Dante. Ciò significa che Dante credeva davvero di aver vissuto, in qualche modo, un’esperienza eccezionale; di aver ricevuto da una divina ispirazione quella conoscenza dello «stato delle anime dopo la morte» che costituisce l’oggetto del suo poema. «Se è “finzione” – riprendiamo ancora le considerazioni di Mineo – la condizione di visione corporale del mondo di là, non può essere “finzione” (per la gravità che non potevano non assumere indicazioni siffatte nel medioevo) l’indicazione in sé di una eccezionalità di condizione. Si deve dunque dedurre che l’itinerario interiore si è svolto in condizioni di divina illuminazione, quando non anche di visione divinamente spirata. Dalla verità dell’illuminazione divina discende la verità dell’apprendimento di Dante, cioè dei fatti, delle nozioni e delle profezie che egli dovrà comunicare, insomma la verità del messaggio profetico». Dante era dunque convinto di aver ricevuto una divina ispirazione a comporre la propria opera. Il fatto che noi moderni possiamo sentirci distanti da quella cultura, che metteva poesia e profezia quasi sullo stesso piano, non ci esime, nell’interpretare l’opera, dall’obbligo di prendere sul serio questa sua convinzione.
La Commedia come “visione”
Nel canto di Cacciaguida, il trisavolo invita Dante a rendere manifesta la sua «vision» (v. 128). Vi sono diversi indizi che autorizzano l’interpretazione di questo termine in senso propriamente mistico. «Non sembra autorizzato – osserva ancora Mineo – supporre che un cristiano del Trecento rappresentasse situazioni di elezione, visione, rapimento, servendosene solo come di metafore di comuni esperienze intellettuali. In assoluta convinzione Dante poteva credere che certe idee ricorrenti, certe immagini, certe speranze, certe nozioni e certe sicurezze dottrinali potevano essergli state comunicate per gratuita illuminazione»2. In questa direzione, un indizio di grande interesse ci è fornito proprio dal passo del Purgatorio che abbiamo qui antologizzato, e che potrebbe apparire a prima vista del tutto estraneo alla questione.
Da Bonagiunta allo Spirito santo
A prima vista si tratta, come è noto, di una semplice questione di storia letteraria. Il siculo-toscano Bonagiunta Orbicciani da Lucca definisce i caratteri della scuola a lui successiva (il «dolce stil novo», che proprio da questi versi prenderà il proprio nome) e li identifica nella totale aderenza dei nuovi poeti all’ispirazione amorosa. Secondo la proposta interpretativa di Mineo, però, il passo può essere letto in maniera assai più sottile: «Il termine “spira” era usato sia per indicare l’ispirazione poetica che quella profetica e mistica. Il termine “dittare” si riferisce sia alla composizione di opere poetiche di alto stile sia all’atto dell’ispirazione divina. Anche il termine “notare” può aver riferimento all’atto dell’accoglimento di un messaggio divino. Colui che ispira è Amore, che può essere sia il sentimento d’ordine religioso-morale ipostatizzato nella Vita Nuova sia l’Amor divino, lo Spirito santo». Ed è proprio quest’ultima l’interpretazione suggerita dal critico: un’interpretazione che sembra provata dal fatto che «nello stesso canto, colui che “ditta” è chiamato “dittatore” e questo è un termine adoperato da Dante quest’unica volta in volgare; pure una sola volta egli ha adoperato, nella Monarchia (III, iv, 11), il corrispondente termine latino, dictator, e in questo caso come predicato di Dio e alludendo all’ispirazione della sacra scrittura. Si può vedere in tutto ciò una dichiarazione, in forma velata, dell’ispirazione divina della propria poesia»3.
Possiamo aggiungere, a queste considerazioni, un’ulteriore notazione: nel discorso di Bonagiunta, il nuovo stile creato da Dante viene fatto cominciare dalla canzone Donne ch’avete intelletto d’amore. Proprio questa canzone, nella Vita nuova, è presentata come frutto di un’ispirazione in cui la lingua del poeta ha per la prima volta parlato «quasi come per se stessa mossa», in una sorta di raptus mistico in cui egli appare posseduto da una forza superiore. Rimandiamo all’analisi della canzone [G8b] e della prosa che la introduce [G8a] per un più puntuale chiarimento della questione. In questa sede ci sembra importante sottolineare il fatto che la citazione messa in bocca a Bonagiunta ci riconduce a un testo giovanile di Dante che viene dallo stesso autore presentato come frutto di ispirazione profetica: difficile pensare che il riferimento possa essere casuale.
Dante stesso (Paradiso, XXV, vv. 1-2) definisce la sua opera «poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra». È probabile che il poeta, con estrema semplicità, abbia voluto dire con queste parole esattamente quello che ha detto. Componendo la Commedia, Dante era convinto che un “dittatore” celeste scrivesse per mano sua. Ciò non gli impediva di costruire con arte il suo poema né di intesserlo, come è giusto che accada di un’opera poetica, di molte bellezze fittizie. Gli garantiva però la possibilità di credere che, nell’atto del suo scrivere, si stesse rivelando (a lui stesso e, per suo tramite, all’umanità traviata) una verità superiore. Una verità che poteva mostrarsi soltanto con la forza della parola; e che, anche per questa ragione, andava gridata ancor più forte.
1 Nicolò Mineo, Dante, in Letteratura italiana Laterza, diretta da Carlo Muscetta, Bari, Laterza, 1980, pp. 184-186. 2 Ivi, p. 163 3 Ivi, pp. 195-196.
|